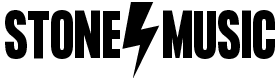La storia della musica è piena di conflitti molto accesi tra diverse sottoculture, fazioni e schiere di fan – alcuni più evidenti di altri.
Ad esempio, mentre l’atteggiamento intransigente del punk nei confronti del prog alla fine degli anni 70 è stato abbondantemente documentato e anche sovrastimato, ci sono altre battaglie che sono passate quasi inosservate.
L’articolo integrale su Prog 27, acquistabile in edicola oppure online cliccando qui.
Prendiamo la critica feroce che è stata perpetrata dagli amanti del jazz nei confronti del rock in tutte le sue incarnazioni. Dal momento in cui Elvis e i suoi amici rubarono la scena ai jazzisti alla fine degli anni 50, molti fan sminuirono il fenomeno come una manifestazione primitiva, infantile e stupida. Tutto questo andò avanti anche dopo che il rock iniziò a inglobare nella sua palette sonora le altre influenze.
Da bambino, Bill Bruford aveva ricevuto degli stimoli abbastanza variegati, con “il giradischi di casa che suonava tutta la roba tipo Big Bill Broonzy, Sinatra e Elvis, mentre il programma televisivo della BBC Jazz 625 forniva un altro genere di ispirazione. Mi fomentai per l’eleganza di Joe Morello, per la perizia compositiva di Max Roach e l’esplosività di Art Blakey”, ricorda mentre cerca di ricostruire la genesi del suo stile.
“Non riuscendo a suonare come loro, iniziai a sviluppare uno stile tutto mio”. Ma quando arrivò il momento di entrare a far parte di qualche band, ecco il dilemma.
“Nel 1968 potevi amare Hendrix o Coltrane, non tutti e due. Quando un jazzista si spostava in ambito rock, come Charlie Watts o Mitch Mitchell, tutti dicevano che si era venduto e veniva scaricato dalla comunità jazzistica. Oggi viene da ridere a raccontarlo, ma all’epoca si trattava di una situazione maledettamente seria”.

Con l’obiettivo di concludere qualcosa, Bruford nello stesso anno entrò a far parte dei Mabel Greer’sToyshop – poi ribattezzati Yes– e da quel momento in poi apparentemente non tornò più indietro (per chi se la fosse persa, cliccare qui per leggere la storia della formazione poi conosciuta come ABWH, nata dagli YES).
Ma dopo essersi guadagnato una reputazione come uno dei migliori batteristi prog suonando con King Crimson, Gong, National Health e Genesis, c’era ancora qualcosa da fare.
Alla fine degli anni 70, Bruford incominciò infatti a virare verso il jazz: inizialmente con i suoi album solisti con Allan Holdsworth, Jeff Berlin e Dave Stewart; poi con quelli realizzati insieme al pianista e tastierista ex Yes Patrick Moraz, fino ad arrivare al 1986, anno di debutto del suo nuovo quartetto, gli Earthworks.
In occasione della pubblicazione del nutrito cofanetto di ben 20 Cd e 4 Dvd EARTHWORKS COMPLETE, viene da chiedersi se il batterista inglese abbia mai avuto la sensazione che il progressive rock degli albori avesse qualcosa in comune con il jazz che ascoltava da bambino.
“A parte Robert Wyatt, credo che ci sia stato ben poco jazz nel prog. Gran parte lo ha portato Steve Howe. Ian Anderson con il suo flauto imitava un po’ Roland Kirk, ma finiva lì. Rick Wakeman era la cosa più distante possibile dal jazz. Il prog e il jazz non avevano praticamente niente in comune”.
Parole forti come al solito, ma sta di fatto che anche se il prog riuscì a portare il giovane Bruford dalla sua parte, il jazz rimase parte di lui. “Penso che fin dal primo giorno con gli Yes stavo cercando inconsciamente di trovare un modo per suonare in un certo modo. Entrare a far parte dei King Crimson è stato un passo importante in quella direzione, perché i Crimson erano più interessati a un tipo di improvvisazione che tenesse conto delle timbriche e dei suoni piuttosto che della velocità con cui eseguire le scale durante gli assoli. Mi vengono in mente brani come Starless And Bible Black, gran parte di THRAKATTAK o pezzi come No Warning e Requiem”.
Tornando agli Earthworks: la prima denomianzione “Bill Bruford Quartet” lasciò presto il posto al più evocativo “Earthworks” e quando il primo omonimo album venne pubblicato nel 1987 fu chiaro che certi duetti tra il sax di Ballamy e la tromba di Bates non avevano niente a che fare con il prog.
Chi andava ai concerti degli Earthworks nella speranza di ascoltare una versione jazz di Roundabout era destinato a rimanere deluso. Ma la nuova band riuscì ugualmente a guadagnarsi il seguito di un pubblico molto fedele, anche se il crossover tra prog e jazz era praticamente assente.
“C’è sempre un piccolo numero di persone stravaganti che sono disposte ad andare a vedere un concerto senza sapere cosa li attende, o ad acquistare un disco in cui non c’è la chitarra. Ma quanti comprerebbero un album in cui oltre alla chitarra manca anche la voce? Una bella sfida.
Indubbiamente all’inizio c’è stato un fuggi fuggi generale, e siamo stati costretti a ricominciare da capo una volta che è apparso chiaro a tutti che tipo di musica proponevano gli Earthworks. In America abbiamo avuto dei buoni riscontri, ma come è possibile ascoltare nel live a Santiago, il Sud America è stato il territorio che ci ha dato maggiori soddisfazioni”. LIVE IN SANTIAGO in effetti è una delle cose più interessanti contenute nel box set.
L’intervista integrale su Prog 27, acquistabile in edicola oppure online cliccando qui.