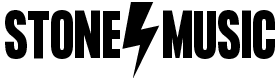In Italia gli Uriah Heep hanno sempre avuto notevoli consensi, sin dal primo tour di giugno 1971 quando tennero sei concerti in nove giorni, tornando ad agosto e a dicembre/gennaio 1972. Ripercorriamo parte della loro lunga storia attraverso 14 album (13 in studio e uno live), dal 1970 al 1980.
Testo: Giovanni Loria | Leggi anche la prima e la seconda parte dell'articolo!
HIGH & MIGHTY, (Bronze, 1976)
Ci sono grandi aspettative per questa nuova opera, presentata in un lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, dove viene invitato il fior fiore della stampa internazionale. Purtroppo, questa volta il passo falso che ne consegue è innegabile, e verrà pagato dal gruppo a carissimo prezzo. Hensley compone quasi completamente da solo, e questa volta la sua penna non è ispirata: a salvarsi sono solamente le poche canzoni nelle quali è coinvolto Wetton.
Il bassista è infatti la voce principale dell’ottima One Way Or Another, e l’esautorazione di Byron, addirittura dal brano che sarà scelto come singolo, è il primo campanello di allarme. Sono apprezzabili anche Weep In Silence e Footprints In The Snow, co-firmate dall’ex King Crimson, ma per il resto c’è davvero poco da salvare. Annusata l’aria che tira, John è lesto a salutare la compagnia, venendo prevedibilmente ripagato con dichiarazioni al vetriolo.
Ma il vero dramma si consuma con la cacciata di David Byron: un momento che per molti segna (ingiustamente) la virtuale fine della parabola Heep, e che è il tastierista a motivare:
David è sempre stato un animale da party, il re del dopo-concerto. Ma eravamo arrivati a un punto nel quale gli interessava solamente di sballarsi, fare festa e rimorchiare quante più donne fosse possibile, e le sue performance dal vivo ne soffrivano terribilmente. Non si poteva più andare avanti così, era il momento di dare un taglio netto con tutto questo, a costo di scelte dolorose.
Sta per cominciare l’ennesimo, nuovo capitolo.

FIREFLY, (Bronze, 1977)
Anche se il diretto interessato nega, David Coverdale, ancora ferito dal fresco scioglimento dei Deep Purple, sembra la prima scelta per ereditare il ruolo di Byron, ma dopo alcune prove momento si tira indietro, preferendo optare per una carriera solista di breve durata prima di mettere su gli Whitesnake. I nuovi innesti rispondono così ai nomi di John Lawton, che aveva lavorato molto in Germania capeggiando gli eccellenti Lucifer’s Friend, e Trevor Bolder, proveniente dagli Spiders of Mars di David Bowie, destinato a consolidare la tradizione di grandi bassisti al servizio degli UH.
Con involontaria comicità, un certamente non efebico Box chiarisce che “come frontman cercavamo qualcosa di meglio dal punto di vista dell’immagine, ma Lawton ha davvero una grande voce, e poi è molto popolare in Germania, dove anche noi abbiamo un pubblico affezionato e fedele”.
In effetti il nuovo arrivato, il cui timbro è molto reminiscente di quello di Ronnie James Dio, non fa certo rimpiangere il pur carismatico predecessore sul nuovo album, che segna almeno in parte il ritorno a tematiche fantasy e ad una scrittura più ariosa. Lawton fa la parte del leone sia sulle disimpegnate, godibilissime Sympathy e Who Needs Me, sia sulle intense e poderose Rollin’ On e Been Away Too Long, oltre a primeggiare nella ballata Wise Man, caratterizzata da un’atmosfera quasi da preghiera, nonché brano più progressivo del lotto assieme alla title-track.
Il clima interno è ancora da notte dei lunghi coltelli: Hensley firma in solitaria sette canzoni su otto, suscitando il risentimento dei colleghi. Sentite in proposito Box.
Qualunque cosa scrivesse, andava usata per forza. E Gerry lo spalleggiava. Finiva per guadagnare molto più di noi, e a questo punto il problema non era più solamente economico, ma minava l’equilibrio stesso del gruppo.

INNOCENT VICTIM, (Bronze, 1977)
Con queste premesse, non sorprende che l’album successivo presenti una suddivisione mai così democratica delle composizioni, e questo senza andare a detrimento della qualità. Gli anni di Lawton sono al contrario caratterizzati dall’ottimo livello medio delle uscite e dalla relativa stabilità.
Gli Heep non sono più molto considerati in Inghilterra, dove ormai furoreggia il punk e i vecchi leoni dell’hard e del prog sono trattati alla stregua di dinosauri; hanno ormai rinunciato a sfondare nel lucroso mercato a stelle e strisce, ma sono muniti di una fedelissima fan-base europea che consente loro di restare, se non proprio sulla cresta dell’onda, assolutamente rispettati.
Uscito con non meno di quattro copertine differenti secondo il Paese di pubblicazione, l’undicesimo lavoro in studio si barcamena con disinvoltura tra il funk puro di Roller, la tracotanza di Free An’ Easy, che, seppur penalizzata da un discutibile pattern di Kerslake, è la canzone più heavy mai scritta dall’act inglese fino a quel momento. Free Me strizza invece l’occhio all’antico successo Lady In Black, con il suo placido andamento flower-power enfatizzato dalle chitarre acustiche.
Al solito, uno dei principali atout di Hensley e soci sta nella capacità di passare da brani disimpegnati e quasi festaioli, con i consueti coretti (è il caso della doppietta iniziale Keep On Ridin’ / Flyin’High), ad episodi assai veementi e dall’innegabile sapore epico, quali Illusion e soprattutto Choices, che davvero non avrebbe sfigurato su un album dei Rainbow coevi.
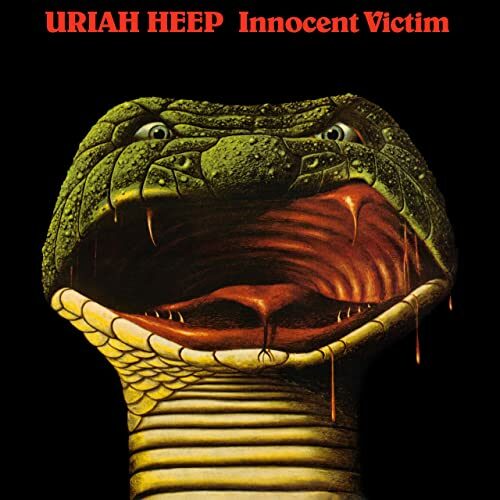
FALLEN ANGEL, (Bronze, 1978)
L’ennesimo lavoro di buona fattura da parte di una band che continua a esplorare le varie sfaccettature dell’hard rock. FALLEN ANGEL al solito media le digressioni più vibranti (I’m Alive oppure Woman Of The Night), le tracce che paiono strizzare l’occhio al pop (Falling In Love, Love Or Nothing o Whad’ya Say, quasi da discoteca), e momenti più enfatici e seriosi, come la title-track.
Possiamo anche parlare di mero mestiere, ma se non figli di un periodo storico ormai lontano, siamo al cospetto di un prodotto onesto e professionale. Ma nella storia degli Heep i rari momenti di tranquillità hanno comunque vita breve: c’è un album in gran parte ultimato nel 1979, che viene abortito improvvisamente quando in rapida successione Lawton e Kerslake abbandonano la band. Il cantante paga un pesante screzio con Hensley, sfociato in una scazzottata, mai confermata ufficialmente: motivo del contendere, la pretesa di Lawton di portare in tour la compagna, in sfregio alle ferree regole interne.
Lee saluta invece dopo otto anni e nove dischi, stufo per la disparità di trattamento che il manager attua fra il suo pupillo Hensley e il resto della band. Il batterista si accasa rapidamente con Ozzy Osbourne, mentre il quarto album dell’era Lawton verrà pubblicato molti anni dopo, come bootleg, con il titolo di TEN MILES HIGH (THE LOST JOHN LAWTON ALBUM). A coronamento del periodo con il secondo cantante, è caldamente consigliato il doppio dal vivo LIVE IN EUROPE 1979, pubblicato nell’86 dalla Castle Records.
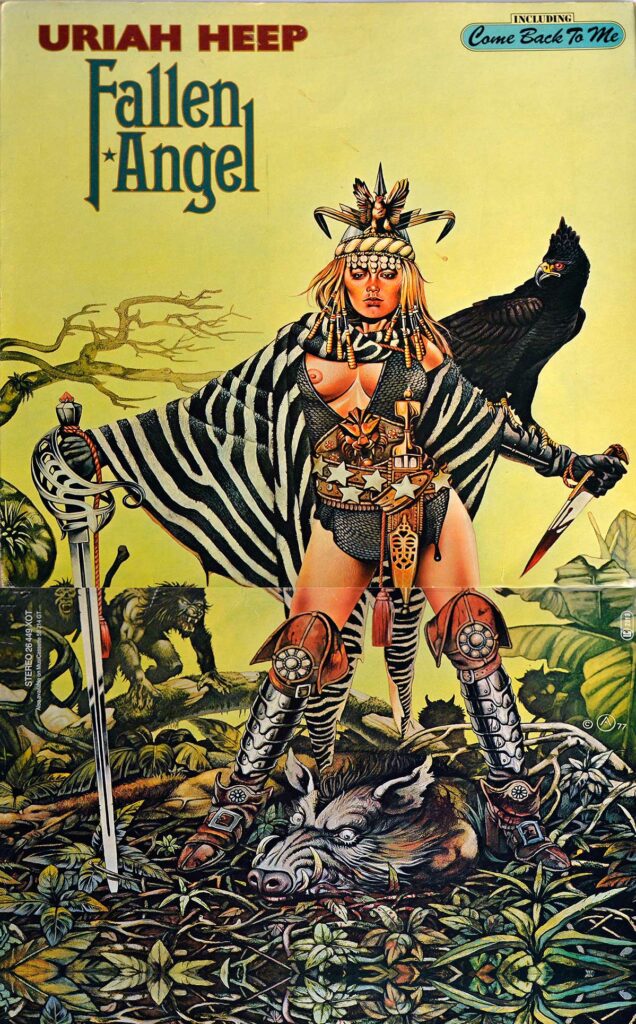
CONQUEST, (Bronze, 1980)
A sostituire i transfughi vengono chiamati due musicisti gallesi dal buon curriculum. In particolare il batterista Chris Slade è una sicurezza, avendo militato per tanti anni nella Manfred Mann’s Earth Band, mentre John Sloman ha prestato servizio sul secondo album dei Lone Star (gruppo a cavallo tra hard e pomp guidato dal chitarrista degli UFO Paul Chapman). Sloman ha inoltre una grande immagine, che in una band non guasta mai, ed è un valido polistrumentista, disimpegnandosi bene fra chitarre e tastiere.
Il nuovo album ricicla un paio di brani previsti sul mai pubblicato quarto Lp con Lawton. Togliamoci subito il dente: per chi scrive, CONQUEST è un buonissimo lavoro, e se cercate dischi sotto tono degli Heep, è altrove che bisogna guardare. Sloman è inoltre un ottimo cantante, ma il suo timbro funk/soul di scuola Stevie Wonder, affine a quello del più noto Glenn Hughes, è quanto di più lontano si adattasse allo stile del gruppo, o dai gusti del pubblico del rock duro.
L’album in Gran Bretagna vende anche benino (meglio dei tre precedenti ad esempio), e si fa forte di due ballate emozionali (Fools e It Ain’t Easy, che le note di copertina affermano inspiegabilmente essere cantata da Bolder) e di un egregio hard/funk (No Return). Dove cominciano i problemi è in tour, con un Hensley che non fa nulla per nascondere la sua riprovazione:
John era un ottimo musicista, ma non era quello che faceva per noi. Io me ne accorsi subito e infatti avrei voluto con noi Pete Goalby dei Trapeze, ma gli altri non vollero saperne. Dal vivo cantava i vecchi pezzi in una maniera completamente diversa da quella in cui li avevo scritti, qui non si tratta di interpretazioni personali, ma del trasformare i Black Sabbath in Gino Vannelli o viceversa! Non soltanto Sloman non ci stava risolvendo i vecchi problemi, ma ce ne stava creando di nuovi.
E così, al termine del tour del decennale, Ken Hensley, il deus ex machina della band, stanco e sfiduciato, getta la proverbiale spugna. Mick Box, l’ultimo membro originale superstite, porta avanti la baracca per un po’, pubblicando un dimenticato singolo (Think It Over) con un nuovo tastierista, Gregg Dechert. Nel 1981, dopo un infruttuoso tentativo di rifondare il gruppo con il vecchio amico David Byron, si arrende anche lui. Sembra la fine per gli Uriah Heep, ma, come vedremo, il vecchio leone ritornerà più agguerrito che mai, portando avanti la gloriosa sigla fino ai giorni nostri. Ma questa è un’altra storia, che prima o poi vi racconteremo.