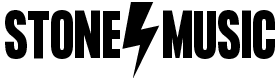Eddie Vedder era solo un ragazzino spaesato
Edward è un bravo ragazzino ma, come i suoi insegnanti delle elementari dicono sempre a sua madre, è anche molto sensibile e troppo taciturno. La mamma e il suo secondo marito fanno del proprio meglio perché lui si senta sempre amatissimo e non vogliono dargli alcun dispiacere; così, Edward cresce senza mai neanche immaginare che il suo vero padre vive, in realtà, da qualche altra parte degli USA. Ci sono cose, però, che non hai davvero bisogno di sapere, perché è il tuo cuore stesso a fartele comprendere e lui sente che c’è una grossa mancanza nella sua vita, un vuoto che lo fa sentire diverso da tutti i suoi amici e che gli fa apprezzare la solitudine più di qualsiasi altra cosa.
La prima chitarra di Eddie: un regalo della nonna
Seduto di fronte all’oceano, sulla spiaggia di San Diego, in California, Eddie si perde con lo sguardo tra le onde e immagina se stesso a cavalcarle. Ha appena compiuto dodici anni quando la nonna gli regala la sua prima chitarra e la sola vera alternativa alle ore e ore trascorse da solo in spiaggia. Sì, perché la musica lo trasforma dentro e diventa l’unica lingua con cui riesce a esprimere quel disagio esistenziale ancora inspiegabile. C’è in particolare un disco in cui Edward si ritrova, un album che uno zio gli ha regalato: QUADROPHENIA degli Who diventa casa sua e non c’è accordo del disco che lui non sappia suonare. Edward, che tutti ormai chiamano Eddie, suona così bene da attirare l’attenzione e l’approvazione degli altri ragazzini della sua età e l’adolescenza diventa, in qualche misura, meno pesante. Non c’è nulla che non si possa affrontare con una chitarra, gli Who e una tavola da surf, nemmeno sapere che il tuo vero padre non è quello che ti ha cresciuto, ma quello che è appena morto e che hai sempre creduto un semplice amico di famiglia.

Eddie Veddere e Pete Townshend: il mito degli Who
Eddie incassa il colpo, studia e lavora come un pazzo per mantenersi, vive in una topaia, ma va bene così. Riesce anche ad andare a vedere gli Who e a farsi firmare un autografo da Pete Townshend, che è sempre e comunque il suo mito. Lo incontra nel backstage, dove si è intrufolato eludendo la sicurezza. Si fa avanti e chiama Townshend con tutta la voce che ha; il chitarrista degli Who gli si avvicina e gli dà un buffetto sulla guancia, poi gli firma una foto e gli regala il suo plettro. “Restituiscimelo se non ti porta bene!”, gli dice congedandosi. Quando qualche settimana dopo Eddie ritorna a Chicago, si sente un altro, cambia anche cognome, riprendendo quello della madre, e decide che è ora di fare sul serio con la sua musica. Il resto è storia, o quasi.
Eddie Vedder e i suoi Pearl Jam diventeranno ciò che sappiamo e la loro musica racconta ancora tanto di quel ragazzino solitario e taciturno di un tempo. Il successo è irrefrenabile ed Eddie non può non esserne travolto. Tutto cambia intorno a lui, ogni cosa diventa più grande, più veloce e meno gestibile, ma non si torna indietro, mai. È il 14 luglio del 1993 e a Londra fa stranamente molto caldo. La Brixton Academy è piena come un uovo e a Eddie batte forte il cuore. Eddie si sente stanco e vorrebbe mollare. Forse non è tagliato per questa vita o, forse, dovrebbe solo staccare la spina per un po’. Quando il concerto finisce, gli sembra di essersi tolto un dente e rientra nel backstage senza entusiasmo. Poi si sente chiamare ad alta voce. Pete Townshend è lì di fronte a lui, gli sorride e gli porge una birra. “Grande concerto. Grande energia”, gli dice.
Eddie si sente piccolo piccolo, perché non può mentirgli, non a chi lo ha accolto in QUADROPHENIA così tante volte, e allora si sfoga, addirittura piange. Tira fuori dalla tasca dei jeans il plettro che Townshend gli aveva regalato una vita fa e gli dice: “L’ho sempre portato con me, ma se vuoi te lo rendo”. Townshend lo abbraccia e da quel momento tra i due si crea un legame ancora più forte, perché condiviso.

Poi, i due intonano insieme:
Let me flow into the ocean
Let me get back to the sea
Let me be stormy and let me be calm
Let the tide in and set me free…
Questo articolo è apparso integralmente nel numero #57 di Classic Rock Italia, in edicola da fine luglio.
Testo: Cristiana Turchetti