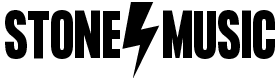La Rock’n’Roll Star dell’epoca glam si è definitamente trasformata in una Blackstar.
La notte del 10 gennaio la stella del rock registrata all’anagrafe come David Jones e nota al mondo come David Bowie ha concluso la sua orbita terrena e la sua luce ha repentinamente smesso di brillare, con uno di quei “coup de theatre” di cui è sempre stato maestro indiscusso. Nulla era trapelato della sua battaglia – ormai evidentemente perduta – con il cancro, che (sembra) lo aveva assalito ben 18 mesi prima. Ci eravamo fidati (o meglio: abbiamo sempre fortissimamente voluto fidarci) delle ripetute rassicurazioni di Tony Visconti, che appena un mese fa aveva detto in un’intervista che l’amico di sempre era in “ottima salute”. E invece no.
Qui in Italia l’abbiamo saputo di prima mattina, il giorno dopo, ed è stato un bruschissimo risveglio, paragonabile a quello che avemmo il 9 dicembre 1980, apprendendo all’ora della colazione che John Lennon era stato ammazzato da uno psicopatico davanti al suo appartamento di New York. Simile la forza deflagrante con cui la notizia si è fatta largo nella nostra addormentata consapevolezza, diversissima la modalità: se 35 anni fa l’apprendemmo via radio e tv, stavolta sono stati i social network e il web – via telefono e Pc – che ci hanno scagliato in faccia quel titolo che mai avremmo pensato di leggere (almeno: non così presto) e che ci ha dato l’impressione di stare vivendo una sorta di incubo: “David Bowie dead at 69”.
Poi la speranza che si trattasse di una bufala o, hai visto mai, dell’ennesimo escamotage spettacolare – come quella volta che all’Hammersmith Odeon di Londra annunciò il presunto ritiro dalle scene, con la ricerca frenetica di qualche autorevole testata che mettesse in dubbio la veridicità della notizia, ma niente da fare: solo conferme su conferme, dal figlio Duncan, dalla stessa famiglia dell’artista, e anche dal sito ufficiale: “David Bowie è morto in pace oggi, circondato dalla sua famiglia dopo 18 mesi di coraggiosa battaglia con il cancro”. Infine, il post su Facebook e Twitter di Tony Visconti, “portavoce” non ufficiale durante tutto quest’ultimo periodo: “Lui ha sempre fatto quello che voleva fare. L’ha voluto fare alla sua maniera e l’ha voluto fare al meglio. La sua morte non è stata differente dalla sua vita – un’opera d’arte. Ha creato BLACKSTAR per noi, il suo dono d’addio. Io lo sapevo già da un anno, che è così che sarebbe accaduto. Non ero, tuttavia, ancora preparato per questo. Era un uomo straordinario, pieno d’amore e di vita. Resterà per sempre con noi. Per adesso, la cosa da fare è piangere”.
Avremo modo con calma, nei mesi a venire, di ripercorrere, riesaminare e, se del caso, (ri)valutare il lascito artistico di colui che ormai tutti siamo abituati a definire “Duca Bianco”. Ma si può invece dire fin da subito che BLACKSTAR, il 28° album di studio di Bowie, uscito tre giorni prima della sua scomparsa, assume ora una luce diversa, si rivela per quello che in definitiva è: un testamento, l’ultimo atto di un uomo (prima ancora che un artista) che sta lottando disperatamente con la malattia ma sa di aver già perso la battaglia. Ora è chiaro (e come diamine abbiamo fatto a non accorgercene prima?): Bowie sapeva di avere i giorni contati, forse addirittura pensava che se ne sarebbe andato prima dell’8 gennaio, giorno del suo 69° compleanno – ergo, prima dell’uscita del disco.
Pensate a quando su Dollar Days intona “If I never see the English evergreens […] / It’s nothing to me” (“Se non rivedrò mai più la sempreverde natura inglese […] / Non conta per me”), o a come, su I Can’t Give Everything Away, parla di “disegni di teschi sulle mie scarpe”. Per non parlare dei due pezzi-chiave dell’album, Blackstar e Lazarus, video e testi circondati da un alone di morte e disfacimento, disseminati di teschi, rituali funerei, (improbabili) resurrezioni, letti d’ospedale e armadi che diventano bare.
“Look up here, I’m in heaven / I’ve got scars that can’t be seen” (“Guardate quassù, sono in cielo / Ho delle cicatrici che non possono essere viste”), canta su Lazarus. E poi ancora, ad libitum: “Oh, I’ll be free / Just like that bluebird / Oh, I’ll be free / Ain’t that just like me” (“Oh, io sarò libero / Proprio come quel pettirosso blu / Oh, sarò libero / Non è una cosa da me?”). E in effetti, sì: una consolazione, se ci può essere nella mestizia di queste ore e di questi giorni, è che è stata un’uscita di scena “alla Bowie”. Folle, spettacolare e mai banale, come ci aveva abituato da sempre.
L’articolo completo, a cura di Francesco Donadio, è su Classic Rock n.39, disponibile qui.