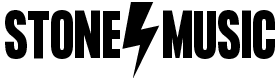Facciamo un gioco: fingiamo che il 2020 sia stato un anno normale. Ecco i migliori dischi pubblicati negli ultimi 12 mesi, secondo la redazione di «Classic Rock».
5. Deep Purple, WHOOSH!

Il terzo disco consecutivo registrato con il produttore visionario Bob Ezrin
fotografa una band in gran forma e, forse sorprendentemente visto da quanto tempo sono in attività, ancora in grado di realizzare alcune delle canzoni più cazzute, coinvolgenti e d’impatto di tutta la loro carriera.
Brani dal sapore epico, sotto i quattro minuti e traboccanti d’idee: Ian Gillan è di una lucidità assoluta, sia come cantante che come paroliere, mentre a livello musicale le esecuzioni sono esemplari, sia individualmente che come ensemble.
L’unico superstite dei Purple classici, Ian Paice, mantiene un groove preciso ed
essenziale, la gamma tonale delle tastiere di Don Airey crea paesaggi sonori precisi, e la fluida precisione di Steve Morse alla chitarra lascia senza fiato.
I Purple di oggi sono tecnicamente eccellenti come al solito, ma è la somma delle loro capacità, individuali e di gruppo, ad apparire più grande che mai. Nessuno cerca di imporsi sugli altri in WHOOSH!, semplicemente perché tutti suonano e creano musica come parte di un’unica entità.
4. The Flaming Lips, AMERICAN HEAD

Prodotto con l’assistenza del solito Dave Fridmann e organizzato come da consolidato copione su sonorità avvolgenti, morbide e visionarie, AMERICAN HEAD evidenzia un’ispirazione più vivida rispetto alle prove più o meno recenti della band americana, e le sue tredici canzoni – mai troppo dilatate o dispersive – sono altrettanti quadretti policromi che tutti assieme vanno a comporre un moderno affresco psycho-pop di notevole forza suggestiva e aggraziata intensità.
3. Joe Bonamassa, ROYAL TEA

In mani meno capaci, sarebbe potuto sembrare un trip di puro egocentrismo: il
tipico fanboy americano cresciuto a pane e blues che torna nella terra promessa per risciacquare i panni a Abbey Road. Ma con ROYAL TEA, Joe Bonamassa cambia le carte in tavola, aiutato dall’ex chitarrista dei Whitesnake Bernie Marsden e dal paroliere dei Cream Pete Brown: attinge ai classici del british blues, aggiungendovi il suo tocco personale. E si lascia ispirare, ma non sopraffare dall’ombra dei Beatles.
Il sommesso mormorio orchestrale di When One Door Opens annuncia che stavolta le cose saranno diverse. E così è in effetti, con Joe che spinge le sue capacità autorali al limite nello psycoblues hendrixiano I Didn’t Think She Would Do It, e mostra una sincera vulnerabilità in A Conversation With Alice, che allude alle sue recenti terapie. Perfino nel boogie più tradizionale di Lonely Boy la
formazione stellare che lo accompagna suona con un’urgenza tale da far pensare a una premonizione dell’imminente pandemia.
2. AC/DC, POWER UP

Il titolo del disco, come anche il nome del gruppo, dice tutto. Come ha dichiarato Angus Young a «Classic Rock»: “Quando collegavo la chitarra, sentivo sempre di
entrare in un’immensa rete elettrica”. Da questo punto di vista, POWER UP è perfetto. E anche se il fragoroso brano iniziale ha un titolo atipico per una canzone degli AC/DC, ci saluta con una scarica di energia molto familiare: un riff scatenato che scalcia, la voce di Brian Johnson che raspa, un assolo ficcante di Angus e un coretto che richiama Thunderstruck. Insomma, gli AC/DC che fanno quel che gli riesce meglio: rock’n’roll ad alto voltaggio.
“Questo è per Mal”, ha detto Angus, così come BACK IN BLACK anni fa fu per Bon Scott. E POWER UP mantiene fede al suo titolo. Gli AC/DC sono di nuovo vivi.
1. Bob Dylan, ROUGH AND ROWDY WAYS

Eccoci al trentanovesimo disco di studio di un signore che ha da poco compiuto 79 anni e che secondo una corrente di pensiero abbastanza in voga non ha più molto da dire.
Le equazioni facili sono la specialità di un mondo distratto e superficiale, e così per molti ROUGH AND ROWDY WAYS è solo l’ennesimo disco di un artista che
molte primavere addietro fu un faro luminoso da seguire, ma oggi emana il bagliore sempre più fioco di una candela ormai consumata. Eh no, troppo comodo.
Predisporsi pigramente all’ascolto di un disco di Dylan non è mai una buona idea:
stiamo parlando di un maestro della parola, anzi di colui che ha insegnato a tutti come va scritta una canzone. E che continua a farlo anche in questo disco, registrato con la sua fedele backing band e pochi discreti ospiti (Fiona Apple, Benmont Tench, Blake Mills, Alan Pasqua e Tommy Rhodes) e anticipato dall’ipnotico torrenziale bilancio generazionale di Murder Most Foul e da quella che è forse la canzone più schiettamente autobiografica mai scritta da Dylan, I Contain Moltitudes.
In apparenza dimesse e quasi soporifere ballad di sapore country-blues, le canzoni prendono vita dopo ripetuti ascolti e con i testi alla mano crescono fino a rivelarsi formidabili. Un Poeta che vuole incendiarsi d’ispirazione fino all’ultimo soffio di vita, ecco cos’è Bob Dylan.